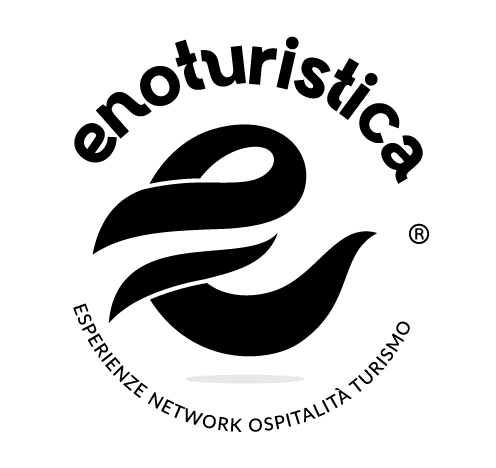Se guardiamo da vicino, il sommelier è storicamente colui che assaggia, verifica, presenta, abbina e serve il vino. Ma in un mondo del vino che negli ultimi anni è cambiato radicalmente, con un pubblico sempre più curioso, informato e meno incline ad accettare verità assolute, il sommelier sembra non aver seguito il ritmo di questa evoluzione. La didattica alla base della sua formazione, pur con le migliori intenzioni, è spesso rimasta ancorata a modelli tradizionali, quasi dogmatici, che non tengono conto delle nuove dinamiche del settore. E così, il rischio di vedere il sommelier ridotto a un ruolo tecnico, un semplice esecutore di gesti impeccabili ma svuotati di significato, diventa sempre più reale.
Questa riflessione, espressa anche dal mio stimato collega e amico Riccardo Margheri nel suo brillante pezzo “Sommelier, ritualità e rigidità fanno bene al vino?”, sottolinea come l’eccesso di ritualità e rigidità nelle pratiche della sommellerie finisca per alienare un pubblico più giovane, meno disposto ad accettare regole che sembrano distanti dalla convivialità e dal piacere spontaneo che il vino dovrebbe evocare. Riccardo, con il suo stile arguto e provocatorio, mette in evidenza come un sommelier che si irrigidisce dietro gesti cerimoniali e dogmi nozionistici perda l’occasione di creare un vero ponte culturale tra il vino e chi lo consuma.
Il contrasto tra teoria e pratica è infatti un nodo centrale della questione. I corsi per sommelier, a qualunque livello, sono caratterizzati da un approccio tecnico e nozionistico. Si impara a memoria un’infinità di denominazioni, vitigni, zone di produzione, caratteristiche organolettiche e regole di abbinamento. Un bagaglio di conoscenze vastissimo, in cui è facile perdersi, ma che dovrebbe essere il punto di forza di chi si fregia del titolo di sommelier.
Tuttavia, tutto questo sapere viene davvero utilizzato per arricchire l’esperienza di chi si avvicina al mondo del vino?
La risposta, troppo spesso, è un malinconico “no”. Partecipare a una fiera del vino o a un evento di degustazione è talvolta un’esperienza frustrante, soprattutto quando ci si imbatte in sommelier che, pur avendo accesso a un immenso patrimonio di conoscenze, si limitano a servire il vino senza approfondire. Al cliente curioso, che vorrebbe sapere qualcosa in più sull’azienda, sul territorio o sulle caratteristiche peculiari del vino, vengono offerte risposte generiche, quando non evasive. E qui sta il cuore del problema. Perché si dedica così tanto tempo a insegnare ai sommelier nozioni tecniche, se poi queste non vengono utilizzate nel momento in cui servono di più? Questo contrasto tra la teoria appresa in aula e la pratica vissuta sul campo è emblematico di una disconnessione che il mondo della sommellerie non può più ignorare.
Il cuore di questo problema risiede anche nell’approccio didattico adottato nei corsi di formazione. Si parte spesso dalla vigna, trattando temi come la fillossera, i portainnesti e le tecniche colturali in modo estremamente tecnico, lasciando i neofiti spaesati. Invece di costruire una base pratica e accessibile, si rischia di alienare chi si avvicina per la prima volta al mondo del vino. Una didattica che non collega in modo chiaro il lavoro in vigna al calice è una didattica che fallisce nel creare interesse e coinvolgimento.
Inoltre, si ignora quasi del tutto la dimensione istituzionale e politica della filiera. I sommelier raramente comprendono appieno l’importanza di strumenti come i registri delle varietà vitivinicole, i disciplinari di produzione o le politiche agricole comunitarie che determinano il futuro del settore. La mancata trattazione di questi temi priva i corsisti di una visione complessa del mercato e delle opportunità economiche offerte dai finanziamenti europei. Allo stesso modo, il tema delle varietà resistenti, come i Piwi, è affrontato solo marginalmente. Eppure, queste varietà rappresentano il futuro della sostenibilità vitivinicola e avrebbero bisogno di maggiore attenzione in un percorso formativo aggiornato.
Agli eventi e alle fiere, il sommelier dovrebbe essere un narratore, un interprete capace di raccontare il vino e l’azienda che rappresenta. Eppure, troppo spesso il ruolo si riduce a quello di un esecutore tecnico, che serve il vino con gesti impeccabili ma che non riesce a trasmettere il valore umano e culturale del prodotto che ha tra le mani. Questo non è solo un problema per i sommelier, ma per l’intero settore: se chi ha il compito di rappresentare il vino non è in grado di farlo in modo coinvolgente e appassionato, come possiamo aspettarci che il pubblico si appassioni davvero?
Oggi il sommelier deve diventare un narratore. Non un cantastorie, ma un ambasciatore del vino e del territorio. Deve essere in grado di guidare il cliente attraverso un’esperienza che va oltre il gusto e coinvolge la storia, la geografia, la cultura. Questo richiede un approccio che non si limita al “cosa”, ma si estende al “perché” e al “come”. Perché quel vigneto si trova proprio lì? Come il lavoro di quella famiglia di produttori si collega a tradizioni antiche o a innovazioni coraggiose? È in queste risposte che si trova il vero valore aggiunto della sommellerie moderna.
In questo contesto, il sommelier non è solo un professionista del vino, ma anche un esempio di responsabilità e cultura, capace di far convivere il piacere del vino con il rispetto delle nuove normative e delle sensibilità sociali. La capacità di raccontare mondi, storie e territori con empatia sarà la chiave per il futuro del settore. E forse, finalmente, l’essere sommelier smetterà di essere un problema, per tornare a essere un’arte.